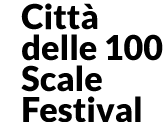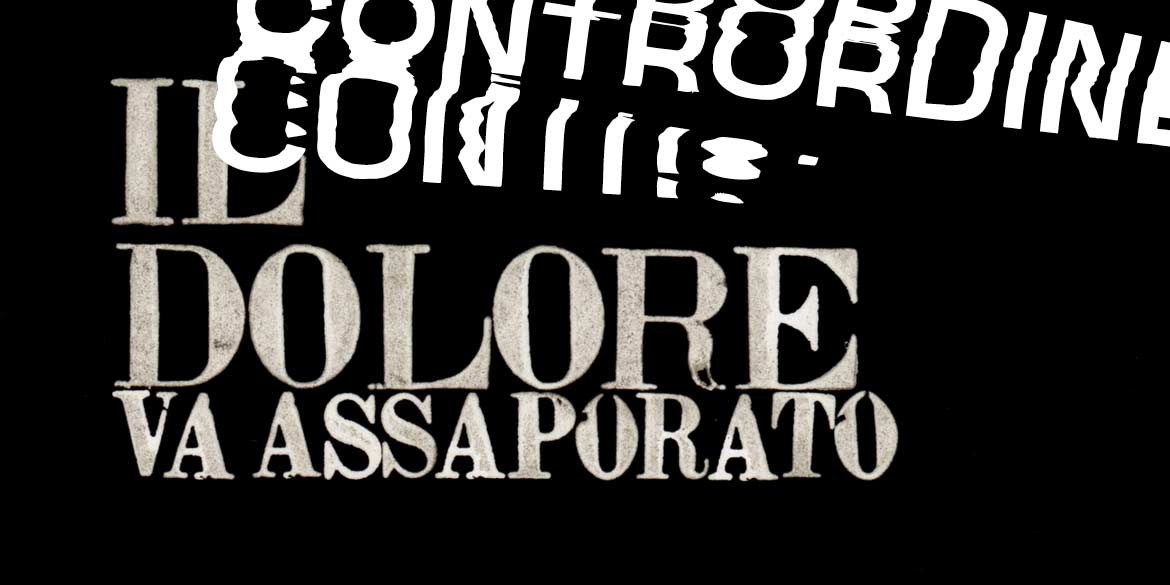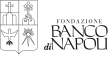Il filo dell’ossessione percorre l’arte del contemporaneo. È esistito un tempo – che a noi appare ormai orientato da una contraddizione in termini – in cui il compito precipuo di un artista era contribuire a una sorta di programma comune del visuale. Un programma la cui massima espressione è il prototipo anonimo e collettivo della cattedrale medioevale o del tempio greco. Proverbiale è il rimprovero che Giorgio Vasari (1511 — 1574) riserva agli artisti del proprio tempo, poco inclini alla disciplina e dediti al capriccio e alla bizzarria, e a una continua ricerca del nuovo e del singolare che sconfina nell’inconsistenza e nella nevrosi. Pontormo, per esempio: «la bizzarra stravaganza di quel cervello di niuna cosa si contentava già mai»; oppure Parmigianino: «cercando di quello che non poté mai trovare, perdé il tempo, spregiò l’arte sua e fecesi danno nella propria vita e nel nome». È l’essenza di quello che secoli dopo, non senza disprezzo, chiameremo “Manierismo”, ossia la breve stagione della crisi in cui gli artisti per la prima volta guadagnarono singolarità e diritto di divergenza in una distorsione del naturalismo che appare spesso morbosa e pulviscolare quanto ragionevole ed essenziale.
Non è un caso che la storiografia dell’arte ponga spesso il confine del contemporaneo lì dove è impossibile far coincidere lo spirito di un tempo con un -ismo, e dove la singolarità dei percorsi artistici manda in frantumi quel palinsesto di aspirazione collettiva: da Vincent Van Gogh al doganiere Rousseau, da Edvard Munch a Egon Schiele, comincia quell’era – non ancora terminata – in cui l’arte è sistematicamente alimentata dal disequilibrio e dalla coltivazione di angoli di cognizione solitari e compulsivi. Perché all’artista si richiede l’estrema coerenza con un mondo interno che è tanto più fecondo e fondato quanto più si emancipa e si sbarazza di congetture collettive e di schemi sociali assimilati senza resistenza né coscienza.
Così Marcello Mantegazza sembra coltivare una singolarità ossessiva nella continua revisione e raffinazione del tipo-umano rappresentato dall’artista, ossia quella maschera sociale cui spetta spendere l’esistenza a disfarsi di quegli assunti su cui necessariamente si basa il reciproco affidamento. L’artista quindi deve correre il rischio fatale di un’asincronia, di una disconnessione dalla sfera dell’ordinario per tenere fede, come Diogene, a una sola regola interna, ma portata al parossismo di una coerenza impossibile. Tautologie e paradossi è una di quelle esplorazioni in ciò che è al contempo sconveniente e ineluttabile, perché mosso da un’area della percezione della verità che è posta a metà tra il pensiero intrusivo e la conquista di coscienza.
Palazzo Enel dismesso, secondo piano, corridoio a destra: un’infilata di stanze si illumina su un tragitto oppressivamente lineare, impetuosamente regolare. A destra e a sinistra gli uffici riportano tracce e reperti di una vita svanita, ma anche di una strategia di organizzazione collettiva basata su un’euristica che ha fallito, che ha fatto il suo tempo. Lì, nel crollo di quella parabola, è possibile trovare Marcello Mantegazza ad attenderci, e a dirci che avevamo tutti gli elementi per prevedere sarebbe finita così, ma non abbiamo voluto vederli: non esiste vento della storia che non sia capace di sradicare la più granitica determinazione, il più imperativo dei propositi, la più coerente delle ideologie. E così il rigore cinico e impietoso della verifica artistica conduce a conclusioni diametralmente opposte a quelle a cui ci aveva condotto il rigore cinico e impietoso del regime che ha costruito questo edificio, così come il rigore cinico e impietoso del moderno: efficienza, produttività, progresso, volontà di potenza, affermazione, assertività, in una retorica declamatoria ed epigrafica che non può che apparirci ormai grottesca e di magniloquenza inversamente proporzionale alla mole del dubbio e dell’incertezza che evidentemente si proponeva di esorcizzare, di negare, di eludere.
Tautologie e paradossi è una sorta di antologia di aforismi esplosa nello spazio, dove il senso di resa e di vacuità – fisica, ideologica, morale – del palazzo è materia viva adoperata per la significazione dell’operazione. Non siamo qui “nonostante” l’abbandono, né vediamo alcuna opportunità di riempimento parassitario nella sovrabbondanza di un vuoto funzionalmente inservibile. I componimenti di Mantegazza appaiono nelle stanze come persistenze retiniche che non avrebbero potuto che essere qui e ora, come conferme sgradite di un’intuizione che è il visitatore stesso a sentir stridere tra le proprie orecchie, in risonanza con l’indefinita sospensione del luogo: «IL TEMPO È UNA MALATTIA»; «VIVIAMO UNA VITA AFFOGATA»; «QUANDO CHIUDI GLI OCCHI E IL BUIO COMINCIA A MUOVERSI».
Mantegazza, nella tradizione psicanalitica e surrealista, iscrive le sue declamazioni come si premurasse solo di lasciar affiorare messaggi della coscienza che i suoi simili non sanno di portare in petto, come engrammi messi a tacere: «UN GIORNO COME TANTI ALTRI»; «MI SONO DIMENTICATO»; «HO AVUTO UNA VITA STRAORDINARIA SI È SVOLTA TUTTA NELLA MIA TESTA». Rivelazioni talvolta di crudele banalità, che sottolineano un intollerabile ovvio e che quindi, proprio per questo, non vorremmo vedere riportato alla dimensione di ciò che, in quanto elaborato, formulato, verbalizzato nella dimensione pubblica, esiste irrimediabilmente: «CHE SPRECO AMMAZZARSI SENZA ESSERE MAJAKOVSKIJ». Tautologie e paradossi, insomma: profezie che si autoavverano e verità che non possono essere così vere.
L’intervento, organico e pervasivo, si muove secondo un ventaglio di strategie che dalla poesia visiva transita verso una forma arresa e minimale di archigrafia: piccole impressioni a timbro in carattere bodoniano, grandi iscrizioni in scala monumentale, quadrerie di cornici in partiture sconnesse, tutte riportanti brani e versi dei Racconti del sonno (2020 — in corso): una serie di azioni che nascono in taccuini e diari, e che l’artista declina di volta in volta in formati, flussi, processi e media diversi, fino all’affissione stradale o al “meme” sulle reti sociali. Qui, stavolta, diventano edificio. Nelle stanze più piccole, a destra del corridoio, trovano invece posto alcune tele della serie SDCNO – Stati di coscienza non ordinari (2019) in cui i messaggi sono ricavati nel ritaglio di una carta da parati, come la memoria inconscia e inquietante restituita da vecchie mura borghesi. Infine, un intervento originale che nasce da un’intuizione fornita dal luogo: in una stanza in cui l’intonaco si “sbuccia” dalle pareti per via di un’infiltrazione d’acqua, nel grigio del muro nudo e della muffa, affiora il testo «TOPOGRAPHIE DES TERRORS». È il nome che la Germania diede al museo-archivio delle memorie del Nazismo a partire dal 1987. Nella consueta postura di Mantegazza, le opposte insostenibilità del lieve e dell’atroce si mescolano in un vertiginoso cambio di scala. E la “carta geografica” formata dalle isole di intonaco scrostate diventa la topografia di un nuovo, minimo, insignificante terrore che riemerge come fosse stato sempre dormiente sotto quello strato di bianco che crolla.
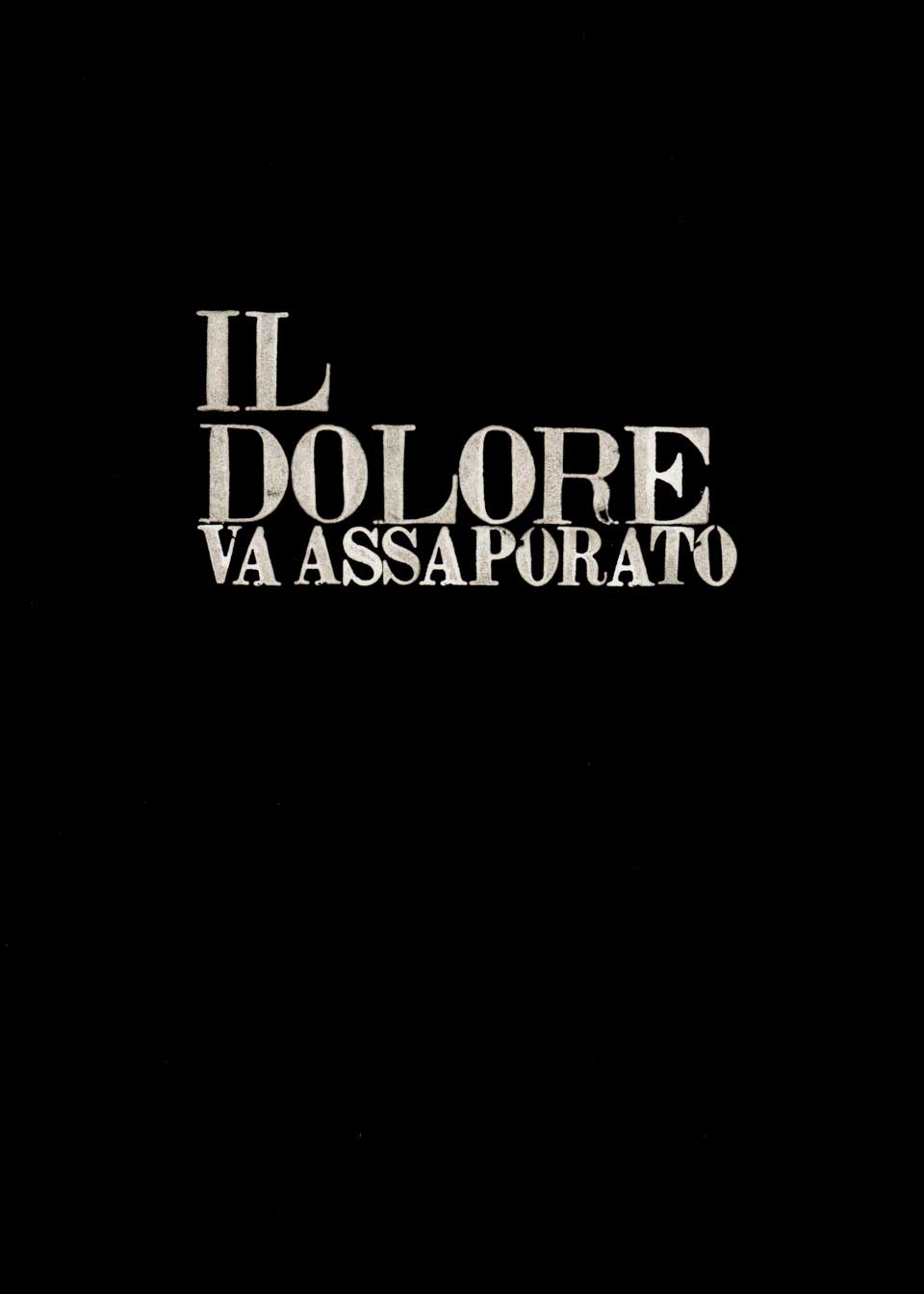
Marcello Mantegazza. Nato a Potenza nel 1974, si è formato presso l'Accademia di Belle arti di Roma. Nelle sue opere – epigrafi, lenzuoli, taccuini, manifesti, tele – esplora i meccanismi della scrittura in una dimensione che oscilla tra l'ultra-privato e l'ultra-pubblico, la poesia visiva e la sintassi delle rivolte di strada, gli aforismi declamatori e la confessione segreta. Timbri, incisioni, graffiti, frottage, spray: tutto ruota intorno alla scomoda e a volte sconveniente assunzione di una postura pubblica per il pensiero nella sua emersione impudica come segno. Il suo lavoro allude spesso alle tassonomie, alle classificazioni, agli archivi, agli inventari come rimedio sconfitto in partenza alla scomparsa, alla perdita della memoria e, in definitiva, alla morte stessa. Le sue opere sono presenti, tra le altre, nelle collezioni di MAAM Museo dell’altro e dell’altrove di Roma, Fondazione SoutHeritage di Matera; Villa Lais di Sipicciano (Viterbo); Bianca Attolico di Roma. Ha esposto in personali e collettive in Italia e all’estero, in particolare presso Macro Asilo, Macro, Museo d’arte contemporanea di Roma; Palazzo dei Priori a Viterbo; Villa Lais a Sipicciano (Viterbo); DIF, Museo diffuso di Formello (Roma); Museo archeologico provinciale di Potenza; Centro comunale Il Ghetto di Cagliari; Cecilia, Centro per la creatività di Tito (Potenza); Centro per l’arte contemporanea Open Space di Catanzaro. Tra le ultime mostre a cui ha partecipato, Una mostra senza Rothko presso Fondazione SoutHeritage, Matera, con Maja Bajevic, Katrin Strobel e un Anonimo frescante meridionale (XVII sec.?), a cura di Angelo Bianco Chiaromonte; e Repertorio scomposto, con in patrocinio dell’Ambasciata cilena in Italia, presso Interno Undici a Bracciano (Roma). Ha collaborato, tra le altre, con le gallerie 3)5 Arte contemporanea di Rieti con la cura di Barbara Martusciello, La Bacheca di Cagliari, Nube di Oort di Roma. Da segnalare la partecipazione con residenze, opere d’arte nello spazio urbano e azioni a manifestazioni come Algoritmo Festival a cura di Serena Achilli a Viterbo, Caprarola e Sipicciano; Face to face, The maieutic machine a cura di Giorgio de Finis presso l’ex carcere di Montefiascone (Viterbo); La giornata dell’arte a cura di Antonio Arévalo a Sipicciano (Viterbo); Urban Vision Festival; Land Art al Furlo. Da segnalare inoltre lo studio visit di Marcello Francolini per l’archivio Panorama della Fondazione La Quadriennale di Roma; la presenza nell’archivio Index, Repertorio d’arte contemporanea in Basilicata di Fondazione SoutHeritage, e la pubblicazione del suo quaderno d’artista Sovrappensiero per le Edizioni Cervo Volante di Tommaso Cascella. A cura di Donato Faruolo, ha installato l’opera permanente Dissipatio H.G. nel castello di Savoia di Lucania (Potenza) nell’ambito di UnMonumental. Riscrivere Passannante (curato con Jessica Salvia, 2025); ha esposto nella personale 404.02 / Una specie di verità presso Porta Cœli Foundation a Venosa (Potenza, 2021); ha esposto nelle collettive Be-Longing, Italy-Egypt Symposium presso il Castello di Monteserico, Genzano di Lucania (Potenza, 2022) e Nile Gallery (Il Cairo, 2023) e 404.05 / Loro. Persistenze dell’oro nel contemporaneo, presso Ori e orazioni, Galleria civica di Armento (Potenza, 2023).