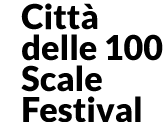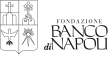Il lavoro di Maria Ditaranto è spesso animato da uno sguardo sospeso su un livello di trasfigurazione della vita: il ricorrente tema del giardino – un Eden lussureggiante come un’esotica foresta pluviale, di grandi foglie grondanti e uccelli colorati – non deve però trarre in inganno. Nasconde infatti un subsidente dissidio, una vena di dolore e malinconia per una promessa di atarassia mancata. I suoi corpi nudi, che si dispongono e si compongono a favore della superficie della tela come in un fregio ellenistico, esprimono sempre un sottile spaesamento, un incredulo presagio di disillusione, un nodo alla gola per la scoperta della finitezza e dell’imperfezione della dimensione umana ancora sedotta da un afflato di infinito. Né mancano momenti di carnalità in cui la ferita metaforica diventa lacerazione materiale del tessuto della pelle e grumo di colore sulla tela, o in cui il corpo, pur alludendo a quella trasfigurazione, resta immanentemente carne, in un loop tra allegoria e metafora.
Auspici e chimere è una sfida lanciata a un linguaggio pittorico, un’escursione non fuori dal quadro, come sarebbe stato per un nouveaux réaliste, ma in un pericoloso terreno di mezzo tra la liminalità del quadro – fisica, linguistica, convenzionale, tecnica, metaforica – e la dimensione dello spazio, dell’ambiente e infine del luogo. Il quadro in quanto dispositivo si dissocia, si disloca, si frammenta, si distribuisce, si nasconde nelle stanze; elude la predisposizione alla contemplazione come finestra affacciata su un altrove; rifugge la costruzione di una scena che ci proietti fuori dal luogo in cui abbiamo piantato i nostri piedi e i nostri polmoni. Non è un caso che questo quadro, da porzione di mondo ritagliata da una cornice che regola e media il rapporto con l’osservatore, si faccia volume solido senza cornice, tagliato nel nudo della parete ed estruso nello spazio, di dimensioni e profondità sempre diverse, sempre in divenire. Talvolta, il quadro gocciola addirittura fuori dalla superficie che per statuto le sarebbe concessa: rivoli di pittura annunciano un debordare fuori dalla convenzione, e ricordano il guano di un volatile intrappolato tra le stanze, indizio di una presenza che ha abitato il palazzo in nostra assenza. La realtà accade, anche al riparo dal nostro sguardo, dalle nostre cognizioni e dalle nostre categorie culturali, e potrebbe sorprenderci da un momento all’altro in un agguato della coscienza.
Il percorso di Auspici e chimere prende corpo al secondo piano del Palazzo Enel, nel corridoio a sinistra, al fianco degli uffici presidenziali. È il cosiddetto “manico della pistola” cui sembra alludere – forse accidentalmente, o forse no, vista la tradizione fascista a riguardo – la pianta dell’edificio. Si annuncia come un riverbero allusivo e incerto della tradizione delle grottesche, quelle decorazioni parietali fatte per partiture in cui si intrecciano motivi architettonici stilizzati, vegetazioni disposte in festoni e volute, ibridazioni seducenti e mostruose di animali chimerici. Le grottesche vennero a suo tempo definite tali perché, nel XV secolo, vennero scoperte sotto il livello del suolo negli ambienti della Domus Aurea di Nerone, diventando presto di moda. “Grotte” per frainteso, quindi, che in origine erano tutt’altro che sotterranee. Riprese nel XVIII secolo per il revival pompeiano e neoclassico, prestarono spesso il fianco a inquietudini rococò e tardo-barocche, mostrando presenze animali fantastiche di terrifica levità in una geometria che si sarebbe annunciata altrimenti innocua.
Maria Ditaranto distribuisce quindi nelle stanze uccelli come apparizioni e testimoni dell’altrove, scarnificati in piccole istantanee quadrate che sembrano quasi dipinte a grisaglia: pettirossi, cardellini, rondini, tortore, corvi, falchi... Fauna ordinaria e domestica che si annida negli angoli degli ambienti generando tensioni che attraversano tutto il campo della fruizione. Non si tratta però, come nelle grottesche, dello spazio della meraviglia esotizzante proprio della teatralità barocca, né dello spazio di un’illusione di sfondamento delle pareti verso una dimensione naturale assente. Semanticamente, quegli uccelli sono lì, in un livello della realtà a noi compresente, verosimile se non reale, e comunque non meno verosimile della nostra improbabile presenza in un palazzo che vive di sospensione e attesa.
Nel procedere delle stanze, i segni di questa allusione si fanno meno ipotetici, inaspettatamente fattuali. L’ultima stanza del corridoio, un ambiente fuori asse che cambia scala ed esposizione, si scopre essere il luogo in cui la falla del potenziale diventa una inquietante falla del reale, in cui la voliera accennata dalla trasfigurazione decorativa esce fuori dai ranghi del puro linguaggio per farsi minacciosamente atto: in questi oltre dieci anni di abbandono i piccioni sono entrati dalle finestre lasciate aperte in questa stanza e hanno popolato i corridoi deserti, talvolta perdendovisi. Il pavimento qui è restato punteggiato di guano. E il rapporto abitante/invasore, presente/assente, reale/finzione, opera/ambiente, natura/cultura, fantastico/orrorifico, cura/degrado, vita/scena sembra invertirsi, o quantomeno diventare più ambiguo. Per iniziativa dell’artista, questa volta la grata è alla porta d’ingresso e preclude il passaggio agli umani, costretti a osservare uno spazio che resta nella disponibilità degli occupanti. Tortore e cardellini lasciano spazio ai piccioni: nel fondo della sala, sottratti alla pura contemplazione, anche i dipinti accolgono questi animali spoetizzati e infestanti, portatori di grigia inquietudine e turbamento, ma anche dell’istanza di una vita che si insinua negli anfratti di ciò che è dato per spacciato.
Auspici e chimere è quindi il titolo di un lavoro che non consiste in una teoria di “pezzi” allestiti per farsi guardare aggredendo un vuoto, ma è un intervento artistico impastato indissolubilmente con le forze e le tensioni di queste stanze colte nel loro essere tali, così e ora, parte attiva della significazione. Se di opera si deve parlare, non ci si deve riferire a ciò che appendiamo alle pareti, ma al palazzo stesso visto attraverso un lavoro di riemersione e re-immaginazione. Un palazzo inteso non solo nella sua componente architettonica, progettata, prevista, ma soprattutto nella sua vibrante indeterminazione, nella sua vita ossimorica tra razionale assertività monumentale e cupio dissolvi di un’elisione urbana. È testimone di un tempo, di un paradigma, di una postura obsolescente, nel suo perdere presenza.
La parola “auspicio” – presagio favorevole, proiezione desiderante – viene dal latino auspicium, avis spicere, “guardare gli uccelli”. Nell’antica Roma, e ancor prima presso gli Osci, era la pratica augurale della divinazione per indovinare la volontà degli dèi attraverso i segni afoni e misteriosi ricavati dall’osservazione del volo degli uccelli. L’auguraculum di Banzi (Potenza), oggi custodita nel Museo archeologico nazionale di Venosa, ne è uno straordinario dispositivo liturgico. Invece, la parola “chimera” – il citato animale ibrido e mostruoso, spesso alato – per estensione è diventata catacresi per utopia, sogno vano, aspirazione mal riposta: un auspicio che si contraddice, che si sterilizza annullandosi o che scommette nell’impossibile, come chimerico è lo stato di ibrida inquietudine di queste stanze. Così la presenza di questi uccelli, realtà o simulacro, “trasforma” lo spazio non solo semanticamente, ma fin nella radice della sua percettibilità. Auspici e chimere, senza produrre modificazioni significative, senza alterare l’esistente, prova a lavorare sulla materia instabile dello statuto del luogo: un palazzo o una voliera, un luogo di abbandono o uno spazio realissimo di proiezione desiderante.

Maria Ditaranto. Nata in Puglia nel 1968, vive e lavora a Potenza. La sua formazione come progettista grafica pone le basi per un’attenzione alla costruzione e alla composizione dell’immagine come campo di forze della significazione. Con il tempo si concentra sulla figura umana e sul corpo, esplorando il confine sottile tra verosimiglianza e rivelazione dell’artificio, con una pittura fatta per strati e interferenze, per ornati ed elisioni, per positivi e negativi. Non solo psicologia del ritratto, della posa, degli attributi oggettuali come iconografie introspettive, ma anche un discorso sul corpo come emblema e frontiera. Questa tendenza alla trasfigurazione emblematica la induce a esplorare anche le sfere della flora e della fauna come campionari del fantastico, ma anche come campi di prova per le facoltà della vita. Per la trasversalità del suo linguaggio, il lavoro di Maria Ditaranto ha catturato l’attenzione di istituzioni civili e religiose, di collezioni private e musei pubblici. Sue opere si trovano nella collezione del Museo provinciale di Potenza, del Museo nazionale di Matera, del Polo bibliotecario di Potenza, del Museo civico dedicato a Mattia Preti a Taverna (Catanzaro), del Museo di Sant'Andrea Avellino a Castronuovo Sant’Andrea (Potenza), oltre che in molteplici luoghi di culto. Ha esposto in personali e collettive in Italia e all’estero, in particolare presso il Complesso di vicolo Valdina della Camera dei Deputati a Roma, il Circolo italiano a Buenos Aires, la Fondazione Mazzullo presso Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina (Messina), la Fondazione nazionale Carlo Collodi (Pistoia), il Castello di Lagopesole (Avigliano, Potenza), il Consiglio Regionale della Basilicata (Potenza), il Museo diocesano di Troia (Foggia), il Mupa di Ginosa (Taranto). Ha lavorato con le gallerie Idearte di Potenza, Koller Galleria di Budapest, OnArt Gallery di Firenze, Koart Gallery di Catania. Con la curatela di Donato Faruolo è stata presente nelle mostre Re—form. Mediterranean art prize, Castello di Monteserico, Genzano di Lucania (Potenza, 2023); 404.05 / Loro. Persistenza dell’oro nel contemporaneo, Galleria civica di Armento (Potenza, 2023), e ha prodotto l’installazione La soglia del corpo, Cappella dei Celestini, Potenza (2025).