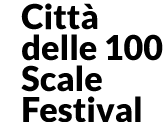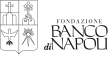La riapertura temporanea ed estemporanea del destituito Palazzo Enel di corso Garibaldi a Potenza è un accadimento che in nessun modo può essere letto in termini “funzionalisti”. Non sarebbero mancate altre volumetrie e superfici predisposte alla produzione di azioni standard, e la riattivazione di un edificio dormiente richiede tutta una serie di brutalità e gentilezze per reagire alle angherie che sono l’effetto collaterale di ogni sconfinamento dall’ordinario. Un’escursione oltre ciò che è normato e codificato dall’algoritmo della burocrazia e dell’abitudine.
La riapertura di quello che per decenni è stato un organo vitale della città – e di una grossa fetta del Sud Italia che riceveva le sue bollette da qui – non può essere solo un fatto tecnico, ma sembra piuttosto necessitare di alcune accortezze. Magari di un dispositivo di mediazione che consenta di “misurare” il nuovo senso della presenza del palazzo nella città e contemporaneamente di misurare la nostra imprevista presenza nei suoi spazi. Come le griglie disegnate sulle piazze rinascimentali o le righe negli ambienti di Daniel Buren, la riconoscibilità del linguaggio di un segno antropico ci consente di appoggiare le nostre cognizioni a qualcosa di raffrontabile, di misurabile, di modulare su cui basare la nostra relazione con ciò che è fuori da noi. Da quei segni sarà possibile desumere quella regola dello spazio che sarà la bozza della nostra proiezione mentale che utilizzeremo per orientarci al suo interno.
Ma non è questo il caso. Perché le istanze di questo luogo non sono puramente spaziali, volumetriche, architettoniche. Non sono razionali, lineari, né possono amministrarsi con un completo dominio mentale, ma sono complicate dai precipitati di una storia che ha lasciato segni e vuoti, aspettative disattese e coscienze assopite. Ecco correrci in soccorso il lavoro di Nicola Di Croce e Marta Magini: uno, ricercatore urbanistico, da sempre impegnato nella comprensione delle strutturazioni cognitive e culturali che danno forma ai luoghi nella loro dimensione antropica, con una imprevista predilezione per l’ambito sonoro e auditivo come campo di indagine; l’altra, artista e performer, fa del movimento nello spazio un dispositivo della coscienza, in quell’area incerta in cui la partitura e la scrittura del gesto si fanno danza, coreografia, progetto, verifica.
Nell’ambiente d’ingresso del Palazzo Enel ci accoglie così un fischio. Faremmo forse fatica a comprendere subito se si tratti di un rumore tecnico e indesiderato, ma la sua modulazione nello spazio comincia già a offrire parametri per misurarci in questa esplorazione: il suono si avvicina o si allontana? È costante o cambia? Segue uno schema ritmico o non c’è modo di ricondurlo a una logica prevedibile, a un modulo? Saliamo la splendida scala “semi-elicoidale” che conduce al secondo piano. Il nostro movimento nello spazio è già musicale, è già partitura. Cerchiamo con la mente il centro del semicerchio che percorriamo, e il ritmo e la lunghezza dei nostri passi si adattano alla porzione di spicchio che decidiamo di percorrere: più larga all’esterno, più stretta al parapetto interno. Compare un secondo suono. Il primo sale, o forse cala. Poi un terzo suono sembra fare capolino, giocando con i nostri canali auditivi. Forse perdiamo il primo. O è il secondo a essersi abbassato? O abbiamo finito per fondere due percezioni distinte? Infine un quarto suono proviene dalla stanza in cima alla scala, dietro a una porta.
La semplice, astratta plasticità dei suoni nello spazio offre la traccia per una giostra di percezioni che non servono solo a chiarificare, a comprendere, a dominare. Servono piuttosto a esplorare una spazialità, una densità, una direzionalità, e in definitiva un’attitudine e una postura nei confronti dell’altro fuori da noi, di quel negativo a partire dal quale ci definiamo come soggetti. Non c'è solo pacificazione con l’ambiente, ma anche smarrimento, disappunto, tradimento di aspettative di comfort.
L’opera, straordinariamente capace di impreviste attivazioni, è il reenachtment di Quattro fischi verticali, sviluppata dal duo Di Croce / Magini per la Cartiera di Vas, in provincia di Belluno, a un passo dal fiume Piave. In quel luogo, lungo il torrente Fiùm, i diffusori sono installati a formare una specie di “arena” sonora, in cui i suoni artificiali si mescolano con quelli naturali. Anche qui, una riattivazione della coscienza, che induce a una nuova considerazione per l’acqua, per il bosco, per la turbina: non solo presenze “oggettuali”, ma elementi di un paesaggio sonoro determinanti per la Cartiera, per la vita economia degli abitanti, e quindi per la loro concezione del rapporto di alleanza con il territorio e con l’ambiente.
A Potenza, Quattro fischi verticali sperimenta la sua funzione di dispositivo rivelatore e problematizzante, misurandosi con un contesto radicalmente diverso ma portando in sé il seme dell’esperienza di Vas. Con tuttavia la capacità di toccare recettori fisiologici, ambientali e culturali totalmente nuovi.

Nicola Di Croce e Marta Magini. La collaborazione tra Magini e Di Croce esplora le potenzialità dello scambio epistolare per la creazione artistica, sonora e performativa. Collaborano alla performance Swinging is like saying no no no (2023) e Richiamo (2024), presentando il loro lavoro in festival e residenze in Italia, anche attraverso momenti laboratoriali. Nel 2024 il duo è in residenza presso Guilmi Art Project (Chieti), Giardino Villa Cappuccini (Perugia) e Spazio ZUT, Foligno (Perugia). Nel 2025 presentano il progetto di mostra Giacinto presso lo spazio indipendente Aarduork (Venezia). Nicola Di Croce è artista sonoro e ricercatore. Il suono è centrale nelle sue attività artistiche e accademiche. La sua ricerca si concentra sul rapporto tra Studi Urbani e Cultura Sonora; è interessato ad approcci qualitativi, partecipativi e creativi orientati all'indagine delle trasformazioni urbane e culturali e all'analisi e al progetto di politiche urbane attraverso metodologie emergenti nell’arte sonora e relazionale. È membro fondatore del centro studi SSH! Sound Studies Hub e ricercatore presso l’Università Iuav di Venezia. Marta Magini è artista multidisciplinare e performer che vive e lavora a Venezia. Dopo una laurea triennale in Design, si laurea in Arti Visive all’Università Iuav di Venezia, e consegue in seguito il Master MAP_PA in Arti Performative al Mattatoio di Roma. A partire da un interesse per il corpo e il movimento, la sua ricerca si muove tra pratiche performative e coreografiche, arti visive e scrittura. Il suo lavoro sul corpo tra mobilità e immobilità indaga la relazione tra soggetto e oggetto, scultura e immagine in movimento, con l’intento di aprire spazi di riflessione sulla produttività e l’improduttività, sia nell’atto performativo che nel processo creativo.