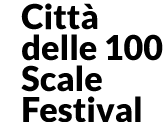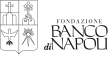Appunti per una riflessione intorno al tema del festival. È intorno alla relazione fuori/dentro che ruota il dialogo tra Roberto Esposito e Toni Negri all’interno del volume “Effetto Italian Thought” (Quodlibet, 2017).
Sovranità e impero

Pubblicato il
La sovranità è la categoria negativa per eccellenza.
— Michel Foucault
I.
In apertura del suo intervento, Esposito definisce in maniera sintetica ed efficace una “serie di motivi” che situano il pensiero di Negri – “uno dei più potenti dispositivi filosofico-politici e teoretici con cui ciascuno di noi ha la necessità di confrontarsi” – nell’orizzonte biopolitico, e dunque oltre il paradigma sovrano:
- la trasformazione del diritto in macchina amministrativa di governance in cui il sistema delle norme subentra all’ordine della legge nella regolamentazione dei conflitti sociali;
- il trasferimento delle strutture giuridiche, articolate in sistemi autopoietici, dal terreno statale a una serie di dinamiche sociali provviste di un crescente grado di autonomia;
- l’interdipendenza globale tra Stati e mercati che destruttura il regime sovrano superando definitivamente il modello interstatuale a favore di nuove forme di coordinamento infrastatuali e ultrastatuali.
In altre parole, i processi in atto destrutturano, nell’elaborazione teorica di Negri, la categoria della sovranità, che agisce sempre per via negativa, “sia attraverso la legge sia attraverso l’eccezione che la sospende, sia imponendo divieti sia eccedendoli”.
La sovranità è la categoria negativa per eccellenza – come ha scritto Michel Foucault.
Ed è proprio contro il paradigma sovrano della tradizione hobbesiana (potere contro stato di natura) che Negri mette in campo il suo pensare affermativo, vitale, energetico, positivo – un pensare che non costruisce affatto le proprie categorie dalla negazione del loro contrario:
non cercare la libertà nel rovescio della necessità, la storia nel rovescio della natura, il comune nel rovescio del proprio.
Qui si manifesta – a parere di Esposito - tutta la potenza vitale del pensiero politico italiano, a partire almeno da Machiavelli:
la politica non si origina dall’annichilimento dello stato di natura, ma ne incorpora la potenza energetica, incanalandola in istituzioni sempre rinnovate dal rapporto costituente con l’origine.
Un ritorno all’origine “per rinnovarsi radicalmente ogni volta che rischia di prosciugarsi”.
È questa la dimensione anti-teologico-politica del pensiero di Negri. Dimensione che, in qualche modo, unisce Negri all’elaborazione teoretica di Esposito.
II.
“Ciò che mi convince meno è la sua interpretazione della situazione attuale”. È sui processi in atto che Esposito non concorda con quanto emerge dalle tesi di Negri, a partire dalla questione della sovranità:
Essa è davvero implosa [– come Negri sostiene –] o si va ristrutturando in quello che potremmo definire un Leviatano 2.0? Ancora: la macchina della sovranità è davvero assorbita in una politica affermativa, così da incorporare ogni “fuori” nel “dentro”; o continua, sia pure differentemente, a produrre nuovi assetti di potere? E il processo di deterritorializzazione ha davvero travolto tutti i confini territoriali in un mondo senza più né centro né limiti?
È proprio intorno a questi interrogativi che muove la critica di Esposito a Negri. A partire da un assunto importante:
La globalizzazione, ancora forte sul piano economico e tecnologico, arretra e si spezza su quello politico. Quella che stiamo sperimentando è anzi la prima grande crisi politica della globalizzazione.
C’è un ritorno in grande degli Stati-Nazione. Elevano nuovi muri, tracciano solchi profondi sulle terre di confine, chiudono le frontiere, rivendicando – accanto al debito – altre prerogative sovrane. Lo stesso terrorismo islamico “cerca di territorializzarsi in un nuovo Stato sovrano”!!! Le guerre civili in atto destabilizzano grandi spazi, consentendo nuove territorializzazioni neocolonialiste.
Ecco che allora la linea di confine dentro/fuori
si approfondisce, incidendosi profondamente nel cuore dell’Occidente...
Il nomos della terra, per usare il lessico di Schmitt, oltre che produzione e distribuzione, torna a farsi spartizione in un nuovo assetto geopolitico del mondo.
Devo confessare che le penetranti osservazioni di Esposito riportano in primo piano anche il ruolo positivo che lo Stato-nazione continua oggi a giocare in una dimensione di economia globale nella quale assistiamo al primato del diritto privato.
Scrive Esposito:
… un residuo di democrazia appare possibile solo all’interno dei singoli Stati nazionali. È solo lì che al momento possono generarsi conflitti politici. (…). Nonostante tutti i suoi limiti e i suoi dispositivi escludenti, al momento lo Stato nazionale resta l’unico soggetto di costituzionalizzazione dei rapporti privati che regolano invece il mercato finanziario mondiale.
A questo punto del suo ragionamento, Esposito sottopone a critica anche le categorie di “moltitudine” e “comune”.
È il suo un discorso complesso che, in questa sede, non possiamo – almeno per per il momento – affrontare, ma sul quale ritorneremo.
Ciò che ci interessa è, invece, riproporre il tema dell’affermazione, del positivo, dell’immanenza.
Può il solo desiderio creare una prospettiva politica? Può un discorso totalmente affermativo della pura immanenza eliminare il limite, la realtà del negativo, il “fuori”? Non occorre forse tener conto sia della “determinazione esterna” che della “determinazione interna”, ovvero “il taglio potere/resistenza che chiama in gioco la questione del negativo”?
La risposta di Esposito – nella sua critica a Negri – è chiara:
…cosa sarebbe un mondo senza fuori come quello di “Impero”? Un’immanenza priva di soglie interne ed esterne? … ho l’impressione che il “fuori” non possa essere espunto, anche perché la sua stessa espulsione sarebbe, in ultima analisi, una categoria negativa.
foto: © Salvatore Laurenzana