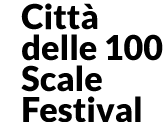Abbiamo visto gli artisti e gli spettatori entrare nel capannone della Metaltecno – il capannone nella zona industriale di Tito Scalo che accoglie la seconda parte del festival – e manifestare meraviglia come è consono fare entrando in una cattedrale.
La meraviglia dell'inattuale

Scritto da
Donato Faruolo
Pubblicato il
Le inattualità si rifugiano una nell’altra in un gioco di trasparenze che nell’instabilità della vibrazione sembrano collimare, in una combinazione che tira fuori un senso dallo scarto di ciò che sembra irrimediabilmente concluso.
Abbiamo uno sguardo e esprimiamo un accordo nel senso della rappresentazione dei tempi che ci rende disallineati, trasversali rispetto alle nostre stesse categorie, e che fa sì che talvolta ci si palesi in riflessi che ci rivelano inaspettatamente a noi stessi.
Chi ha disegnato il capannone della Metaltecno ha certamente avuto diverse accortezze per rendere quello spazio perfino irritualmente “bello” nell’ambito di un’architettura industriale in genere puramente utilitaria ed economica: la scelta del verde menta per le porte metalliche, la lucentezza dell’alluminio, il verde delle piastrelle di ceramica delle zoccolature. Ma parte consistente di quella meraviglia che abbiamo condiviso viene certamente dal fatto di condurre le cognizioni di chi entra verso una visione che riconverte quegli spazi ad altre “produzioni”, a nuove coincidenze nell’ambito dei contemporanei assetti della società.
Un senso pervade la percezione del nostro essere in questa epoca: quello della fine di un ciclo storico, industriale, economico, politico, culturale, in cui è diventato inattuale continuare a pensare di produrre profilati di alluminio nella zona industriale di Tito e in cui è certamente inattuale potersi permettere di costruire un teatro, ancora. Ossia uno spazio da dedicare programmaticamente e ritualmente alle arti performative e in cui esprimere la collocazione dell’arte nella società contemporanea, così come gli antichi mostravano nella cattedrale o nell’acropoli la partecipazione a un comune senso di città intesa soprattutto come pluri-organismo umano, nel bene e nel male. In questa congiuntura le inattualità si rifugiano una nell’altra in un gioco di trasparenze che nell’instabilità della vibrazione sembrano collimare, in una combinazione che tira fuori un senso dallo scarto di ciò che sembra irrimediabilmente concluso. Forse per celebrare ed elaborare quella conclusione stessa.
Di qui, credo, la meraviglia, formalizzata e esplicitata con sottigliezza e senza compiacenza, con secchezza, frugalità, concisione, con limpidezza e feconda ambiguità, in Meno, l’allestimento di Volumezero architecture & landscape (Potenza) e Osa architettura e paesaggio (Roma).
Due le performance musicali, prima e dopo gli spettacoli del 16 settembre: Reflections, live electronics con Dario Satriani e Mimmo Filitti; poi Trasversale, live dj-set e installazioni sonore a cura di Lucio Corvino e Maurizio Inchingoli. Due le performance di danza, con Claudio Massari e Paolo Girolami.
A peso morto, di Carlo Massari, è una performance che con pochi elementi è in grado di costruire tutto intorno il proprio contesto narrativo, storico, sociale. Nessuna scenografia, nessun tappeto, solo luce ambientale, e solo la nudezza dello spazio industriale (che talvolta, in altre ambientazioni dello spettacolo, è lo spazio urbano delle periferie). Un uomo – forse un personaggio senza sesso – con una grottesca maschera di vecchio, una tuta e due sporte di tessuto plastico a quadri – le stesse che usano i senzatetto, gli zingari o le anziane che ancora vendono frutta e erbe nelle città – entra nella scena anticipato da un suono. Sono le sue due sporte, che emettono musica popolare, riverberi di balera, di feste di piazza di altri tempi. Pesano dei ricordi e delle aspettative disattese del personaggio, testimone di una città che non esiste più e che ha spinto ai margini i suoi eroi caduti in rovina.


Paolo Girolami, con il suo Manbuhsa, ha mischiato l’esotico e l’animalesco, il folclore e il bestiale, l’antropologico e l’etologico, attraverso gestualità che appaiono fatalmente lontane, oscure, indecifrabili, vitalmente inquietanti. Ma quando si riconosce la presenza di un’articolazione linguistica in ciò che nell’estraneo vorremmo ricondurre all’innocua disarticolazione, scatta – se non la comprensione – il “riconoscimento” di un comune senso del rituale, di un’azione fondata e finalizzata che, nel suo restare indecifrabile, si manifesta a noi consimile e che forse per questo, a maggior ragione, è in grado di generare turbamento. Una coreografia a due in cui le movenze non possono fare a meno di esprimere un livello di inaspettata armonia. Come in uno specchio asincrono i gesti di Giacomo Todeschi e dello stesso Pablo Girolami vanno in ridondanza, si rispondono, coincidono, e a volte sembrano casualmente incappare nell’interazione. Emergere la precisione, la concisione e la palpitazione di un congegno tanto meccanico (penso agli accordi sconnessi di una macchina di Tinguely), quanto naturale (la precisione di un rituale di accoppiamento animale), quanto sottilmente anti-classico (la Battaglia di dieci uomini nudi del Pollaiolo). Per effetto della ritmica e dello schema di occupazione e misura dello spazio, i loro corpi sulla scena subiscono strani effetti di distorsione, apparendo allungati e scattanti nel parossismo di una composizione alimentata di anti-economico e di anti-intuitivo, e pur sempre armonica.
Una visione determinante, che conferma la danza come uno dei pochissimi ambiti della cultura contemporanea in cui è ancora possibile sentire correnti d’aria che si spostano.
foto © Salvatore Laurenzana